Approfondimenti – Le origini della storia Svizzera
Le prime avventure oltre il San Gottardo
Gli uomini della Svizzera primitiva, gli Urani in particolare, dall’inizio del Duecento avevano trovato nel passo del San Gottardo già pulsante di vita nella pur breve estate una fonte importante di guadagni. Come someggiatori, anzitutto, cioè occupandosi dei trasporti di mercanzie, per i quali ricavavano dazi e pedaggi, in ispecie quella tassa di trasporto che aldilà del passo, in Leventina, si chiamava “forletto” (Fuhrleite) e una tassa di magazzinaggio e di custodia che chiamavano “Susten” (dall’italiano “sosta”); è chiaro che l’intenso passaggio di persone e di merci consentiva ai montanari anche un commercio spirituale: conoscevano il modo di pensare d’altre genti, le vicende d’altri paesi, potevano allargare i loro orizzonti. Il passo agevolava poi il trasporto del vigoroso bestiame alpino verso i mercati di Bellinzona, di Lugano, di Varese e d’altre città lombarde, dove la razza bruna dei bovini era apprezzata e pagata adeguatamente; i Paesi forestali intensificarono così col tempo l’allevamento del bestiame, trascurando l’agricoltura e importando dal Mezzogiorno il grano di cui avevano bisogno.
Poi che la pastorizia richiede meno braccia della campicoltura, le “braccia” in soprannumero, cioè la prole contadina disoccupata, venivano esportate, tanto verso nord quanto verso le Signorie italiane e i loro eserciti di ventura: il terzo guadagno del passo consisteva dunque nel servizio mercenario. Furono queste circostanze economiche, accanto alla mancanza di industrie nella Svizzera rurale e all’eccesso di popolazione, a sviluppare il servizio mercenario. Esso era l’industria dei paesi poveri.
Si recassero nel Mezzogiorno quali someggiatori o quali mercanti di bovini o quali mercenari o pellegrini, gli Svizzeri non tardarono a far confronti e allora la loro terra rocciosa gli apparve anche più avare: quanta fatica e quali rischi per raccogliere un po’ di magro fieno selvatico al margine degli alti boschi e per portarlo a spalla fino alle stalle o in paese, lungo gli scoscesi sentieri dell’alpe, in confronto al grasso raccolto della Brianza e della Pianura padana dove si poteva falciare l’erba fino sei o sette volte in un anno e dove la vita sembrava tanto più facile e benedetta. Quando i loro parroci parlavano in chiesa della Terra promessa, molti tra gli alpigiani dovevano pensare ai paesaggi intravisti nei rapidi viaggi verso la Lombardia, e chiedersi se le Alpi avrebbero sempre impedito l’avventura del Mezzogiorno …
Durante l’età comunale, dopo la grande vittoria dei Milanesi contro il Barbarossa, a Legnano, le terre a sud del San Gottardo erano state trascorse dal vento della libertà; a Torre di Blenio, nel 1182, i vallerani di Blenio e quelli di Leventina avevano firmato un patto solenne, contro la tirannide dei balivi imperiali e per la reciproca assistenza; nel secolo seguente, manifestazioni di libertà, di democrazia terriera si erano ripetute nelle valli del Ticino, sino alla rivolta di Airolo e al giuramento di Biasca (1290-1292); soffocata la rivolta leventinese, le Valli erano cadute sotto la Signoria dei Visconti, cioè erano entrate a far parte di quella giurisdizione che più tardi si chiamerà Ducato di Milano. Sarà il Duca di Milano, durante il Quattrocento, a fortificare Bellinzona mediante i castelli, per farne una delle difese del Ducato contro le alluvioni dei “nordici”, come saranno gli Svizzeri – una volta padroni delle terre a sud del passo – a vedere in Bellinzona la chiave dei passi alpini, quindi l’estrema difesa della Confederazione.
Già nel Trecento gli Urani erano discesi in Leventina; scorribande che si conclusero con ruberie e incendio di villaggi. I Leventinesi, che già intrattenevano rapporti economici con gli Urani (si pensi al San Gottardo e ai pascoli confinanti) conobbero in quelle occasioni la violenza guerriera dei vicini. Non sorprende quindi che, sui primi del Quattrocento, si rivolgessero agli Urani per protezione. Morto il duca Giovan Galeazzo Visconti (1402), il Ducato era in preda a disordini, i Leventinesi volevano da Milano gli stessi privilegi fiscali che il Ducato aveva accordato ai mercanti svizzeri, e da ciò l’appello agli Urani. Questi ultimi, e con essi gli uomini dell’Obwalden, non se lo fecero ripetere; scesi armati in Leventina, conclusero con i montanari del sud un patto di alleanza nel quale i Leventinesi s’impegnavano a pagare ai due Cantoni “protettori” le gabelle versate fino allora al Duca; alleanza avrebbe dovuto essere, ma gli Urani l’intesero ben presto come signoria verso il sud e, quindi, sicurezza sui due versanti del San Gottardo …
Lo stesso anno 1403, contingenti di tutti i Cantoni salvo Berna fecero un colpo di mano sulla Val d’Ossola; la nuova conquista non rimase però a lungo in mano degli Svizzeri. Si vede tuttavia da questi episodi la direttiva strategica ed economica della giovane Confederazione che intendeva assicurarsi su tutto l’arco delle Alpi i versanti meridionali delle montagne, poi che la montagna costituisce una difesa soltanto se si posseggono i suoi due versanti.
Pochi anni dopo la discesa degli Urani in Leventina, i Cantoni primitivi riuscirono a comperare Bellinzona dai conti de Sacco che v’eran discesi dalla Mesolcina, profittando della giovane età e della debolezza del nuovo Duca di Milano.
Ma nel 1422 il Duca Filippo Maria Visconti, cresciuto in età e deciso a far rispettare i suoi diritti, inviò contro gli “usurpatori” della fortezza ducale un esercito possente, comandato da uno dei condottieri più famosi del Rinascimento, il conte di Carmagnola; la sanguinosa battaglia prese il nome da Arbedo, alle porte di Bellinzona e fu per gli Svizzeri disastrosa, malgrado i loro prodigi di valore (1422). Tutte le conquiste fatte a mezzogiorno venivano d’un tratto annullate, gli Svizzeri dovettero ritirarsi nelle loro terre d’origine, temendo persino – se si deve credere al “Libro bianco di Sarnen” – che il Duca arrivasse al “ponte gocciolante e a Göschenen”, cioè che avesse a drizzare una fortezza nella Schöllenen … La disfatta d’Arbedo segnò una battuta d’arresto nella politica verso sud; gli Zurigani, del resto, vi avevano preso parte con scarso fervore e i Bernesi addirittura contro voglia; i primi avevano altri interessi, i secondi guardavano verso la Borgogna.
Quando, poco più tardi, i Bernesi vennero invitati a partecipare a una spedizione nell’Ossola non mancarono di notare nelle loro cronache cittadine che si sarebbe dovuto guardarsi in avvenire “da simili penose e lunghe imprese”. Di tutta la politica lombarda, ai Confederati sconfitti non rimase che l’assicurazione del Duca di qualche esenzione fiscale sino ai fossati di Milano. Poco, in verità. Tuttavia, gli Urani non rimasero a lungo nei loro villaggi. S’intendessero o meno con i Leventinesi, bastò la voce che alcuni mercanti svizzeri erano stati maltrattati e derubati nel Ducato, per indurre gli Svizzeri primitivi a ripassare il San Gottardo (1439) e a scendere lungo la Leventina per attestarsi prudentemente a Pollegio, davanti a Biasca e alla confluenza del Brenno nel Ticino.
Nel 1447 si spegne con Filippo Maria la casa dei Visconti e, dopo il breve intermezzo della Repubblica Ambrosiana (a difendere la quale accorsero anche truppe delle terre ticinesi), subentra la signoria di Francesco Sforza che intrattiene con i Confederati rapporti abbastanza amichevoli.
Ma già con i suoi successori le cose cambiano; i Leventinesi accumulano rimostranze su rimostranze a proposito di vessazioni da parte del Ducato (essi vogliono, insomma, beneficiare di tutti i favori che Milano ha accordato agli Svizzeri) e fanno appello ai Cantoni d’oltralpe per avere protezione nelle controversie con il governo ducale; di più, gli Svizzeri scoprono che il Duca di Milano ha parteggiato con Carlo il Temerario e lo ha aiutato durante la guerra di Borgogna, e però – non appena finita la campagna contro il Temerario – decidono la spedizione verso il Mezzogiorno.
Sul finire del 1478, l’esercito in quel momento più brillante d’Europa, lo stesso che ha distrutto le ambizioni del Duca di Borgogna, passa le Alpi e scende all’assedio di Bellinzona; la “murata” è infranta, gli Svizzeri fanno scorrerie da una parte e dall’altra del Ceneri, poi d’un tratto, ingloriosamente, abbandonano tutto e si ritirano oltre il San Gottardo, preoccupati – si disse – dell’inverno che sopraggiunge e dal pericolo di rimanere isolati dai loro paesi (nel passaggio del San Gottardo, infatti, le valanghe colpirono la retroguardia svizzera, facendo molte vittime). In Leventina, i capi confederati hanno lasciato un presidio di poche centinaia di uomini, agli ordini del lucernese Frischhans Theiling. Poco prima di natale, avanza da Milano l’esercito ducale, si ferma a Bellinzona per il Natale poi, incalzato dagli ordini del cancelliere milanese Cicco Simonetta (calabrese di Caccuri) e contro il parere dei capi militari che vorrebbero attendere la primavera, muove verso il San Gottardo; l’ordine è di procedere alla distruzione ed “eversione” della vallata ribelle, la Leventina, che tanti fastidi dà di continuo al governo ducale. Il 28 dicembre tra Bodio e Giornico avviene lo scontro dei ducali con il presidio svizzero e con i volontari leventinesi comandati dal leggendario Francesco Stanga; i Milanesi vengono ricacciati e molti di essi trovano la morte sul campo di battaglia o travolti dalle acque del Brenno. Particolare di cristiana generosità: nel martirologio della Chiesa di Quinto, dopo la notizia dell’avvenimento redatto il giorno seguente la battaglia, si invoca la pace eterna di Dio tanto sulle poche decine di morti leventinesi e svizzeri quanto sui nemici caduti in combattimento.
Il fatto d’arme di Giornico definì per sempre le sorti della Leventina; il Ducato riconobbe agli Urani la proprietà della valle, eccetto tutta una serie di rivendicazioni dei montanari e s’impegnò a pagare un’indennità di guerra di venticinque mila fiorini. Ora, la sicurezza militare della Lega era garantita anche nel centro delle Alpi, Uri dominava sui due versanti. Non molti anni più tardi, la valle di Blenio veniva ugualmente occupata da truppe dei cantoni primitivi. Gli Svizzeri erano oramai giunti stabilmente alle porte di Bellinzona. Avrebbero esteso la loro avanzata verso la Lombardia?
Furono i grandi eventi della politica europea a deciderli.
Campagne di mercenari in Italia
Gli Svizzeri non erano i soli a guardare cupidamente al “giardini dell’impero”; il re di Francia, pacificato il paese dopo la guerra dei Cent’anni contro l’Inghilterra e consolidata l’unità nazionale grazie alla scomparsa del rivale Carlo il Temerario, si preparava a discendere nella Penisola. Era re Carlo VIII°, brutto e deforme di corpo, spirito fantastico che sognava grandi imprese memorabili (tra l’altro, voleva mettersi alla testa di una lega dell’occidente per cacciare i Turchi dall’Europa) e che era stato animato da un principe italiano, Lodovico il Moro, a muovere verso l’Italia.
La Penisola aveva vissuto in modo agitato e drammatico i primi cinquant’anni del Quattrocento, dilaniata sopra tutto dalle guerre fra le tre potenze del nord: Firenze, Milano, Venezia; poco dopo la metà del secolo, tuttavia, con la Pace di Lodi, aveva raggiunto l’equilibrio e la tranquillità; furono quarant’anni di pace e di benessere, durante i quali venne maturando e stupendamente dispiegandosi quella gloriosa stagione dell’arte e del pensiero che si chiama Rinascimento; le corti delle Signorie erano centri fervidi di cultura, le città s’arricchivano di continuo grazie ai commerci, all’artigianato, alla navigazione; i più geniali artisti, ospiti di Principi orgogliosi del loro mecenatismo, drizzavano monumenti e templi, affrescavano pareti, dipingevano tele, progettavano grandi opere del genio civile. Periodo di alta civiltà, di benessere economico, di eleganza e di lusso: stagione solare dello spirito …
Ed ecco, d’un tratto, come l’addensarsi d’un temporale in pieno meriggio, l’annuncio della discesa di Carlo VIII° che, aizzato dal Moro, muoveva alla conquista del Regno di Napoli (1494), ponendo fine ai brillanti quarant’anni di pace e dando inizio alle sciagure d’Italia; la sua, infatti, fu la prima di tante funeste invasioni – Francesi, Svizzeri, Lanzi tedeschi, Spagnoli, … – che rovinarono la Penisola e la portarono alla schiavitù.
A Milano c’era Lodovico il Moro, come s’è detto. Quando, nel 1476, il Duca suo fratello era stato assassinato nella Chiesa di Santo Stefano, il figlio del morto aveva raccolto l’eredità ducale; ma si trattava di un fanciullo di sette anni, Gian Galeazzo, incapace di regnare e quindi sotto la tutela della madre e del ministro Cicco Simonetta (lo stesso che ordinò alle truppe milanesi la spedizione terminata drammaticamente a Giornico). Lodovico, zio del giovane Duca, cominciò allora la scaltra opera intesa a soppiantare l’erede legittimo del Ducato: ne allontanò la madre, fece cadere in disgrazia e decapitare il Simonetta, divenne tutore di Gian Galeazzo e, quindi, signore e despota del Milanese.
Tipico signore del Rinascimento, raffinato e scellerato a un tempo, amante del bello, dell’arte, protettore di artisti e studiosi, ma anche capace di raggiri e perfidie com’erano nella pratica di un’epoca in cui, accanto alle raffinatezze dell’arte e all’eleganza della vita s’erano infiltrati negli spiriti lo scetticismo, l’immoralità, il gusto smodato dei piaceri terreni, l’irreligiosità. La corte del Moro s’ispirava al modello di quella di Lorenzo de’ Medici, il Magnifico signore di Firenze; a Milano, il Moro s’era fatto mandare da Lorenzo il grande Leonardo da Vinci ch’era divenuto in breve la perla radiosa della corte lombarda; Leonardo aveva modellato il cavallo del monumento al padre del Moro, Francesco Sforza, creatore della nuova dinastia e mecenate di grandi opere pubbliche: il Canale della Martesana, l’Ospedale maggiore, la ricostruzione del Castello visconteo.
Oltre al cavallo, considerato dagli scrittori dell’epoca la più imponente statua equestre di tutti i tempi, il divino Leonardo aveva dipinto due stupende Madonne, affrescato l’Ultima Cena nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, fatto alcuni memorabili ritratti, abbellito l’interno del Castello e compiuto studi mirabili d’ingegneria intorno a problemi d’idraulica e di urbanistica.
Dopo la discesa di Carlo VIII° che, occupata Napoli senza avere incontrato resistenza, era tornato in Francia per morirvi, le vicende di Lodovico il Moro volsero al peggio; come colpito da una serie di maledizioni, fu afflitto da lutti familiari e da altre disgrazie che raggiunsero il culmine quando il nuovo Re di Francia, Luigi XII°, accampando certi diritti ereditari (*) da parte della nonna (ch’era una Visconti, Valentina, figlia di Gian Galezzo Visconti, duca di Milano, e sposa di Luigi di Orléans) fece sapere di scendere in Italia per riprendere Napoli, ma anche per occupare la Lombardia. Era il 1499; l’imperatore Massimiliano, impegnato nella guerra di Svevia contro gli Svizzeri, non poté dare aiuti al Moro, del quale era cognato. Il Re di Francia aveva seimila mercenari svizzeri, entrò in Milano senza quasi trovare resistenza, e naturalmente fece occupare da guarnigioni francesi tutti i castelli del Ducato, compresi quelli di Bellinzona. Il Moro era fuggito. Il famoso cavallo di Leonardo servì da bersaglio alle frecce dei Guasconi e venne irrimediabilmente rovinato.
(*) dal momento che il duca di Milano Filippo Maria Visconti muore il 13 agosto 1447 senza lasciare eredi, i re di Francia discendenti da una Visconti si consideravano legittimi eredi, e consideravano gli Sforza come usurpatori.
S’è accennato alle migliaia di mercenari svizzeri. E’ un capitolo drammatico e fosco della storia, per comprendere il quale bisogna riflettere su due nuove circostanze della vita d’allora, la corruzione dei costumi e le così dette “pensioni” dei Re stranieri. La facilità dei guadagni e le idee pagane dei nuovi tempi, così come l’esempio che veniva dalle corti europee, avevano mutato l’animo dei Confederati; coscienza religiosa e fedeltà alla parola erano scadute nei cuori, contese e delitti s’accumulavano, la smania del lusso e dei piaceri aveva preso le stesse classi popolari, l’immenso bottino di Borgogna – stimolo di corruzione e d’intrighi – aveva creato nuove, improvvise ricchezze, persino i contadini scambiavano i ruvidi panni con il velluto, e in tutto il paese si diffondeva la bramosia dei facili guadagni mediante l’avventura della guerra, perdendosi in egual tempo il senso dell’onesta fatica sulla terra avita o nelle officine.
La corsa al servizio mercenario veniva poi incoraggiata dagli agenti e arruolatori dei Re stranieri, che distribuivano denaro e “pensioni”, cioè regali in monete d’oro e d’argento, e che aizzavano di continuo la cupidigia. C’erano pensioni che andavano nelle casse della Stato (città o Cantone montanaro che fosse) e che corrispondevano a precisi impegni militari, le “capitolazioni”; c’erano però anche pensioni che affluivano segretamente nelle tasche dei capi influenti, dei comandanti militari, degli uomini politici, dei consiglieri; così i condottieri di milizie e i magistrati dei Cantoni promettevano soldati, li reclutavano, li inviavano sui campi di battaglia dell’Europa; siffatta corruzione doveva rivelarsi ben presto fatale per la Svizzera.
Incitato da Massimiliano, anche il Moro si diede a cercare mercenari; la guerra di Svevia terminata, gli fu facile trovarne nella Svizzera orientale, tra i Grigionesi, e nel Vallese dove il vescovo Matteo Schiner – che odiava i Francesi ed era per l’impero – gli fornì migliaia di uomini. Grazie alle nuove truppe del Moro, il Re di Francia perdette Milano; bastarono, come pittorescamente dice il Machiavelli “le forze proprie di Lodovico”, cioè “uno duca Lodovico che romoreggiasse in su i confini”, per sloggiare gli occupanti francesi. Ma anche Luigi aveva denaro a mucchi, si procurò nuove schiere di mercenari, ridiscese in Italia e riuscì ad accerchiare il Moro dentro la città di Novara. Fuori e dentro Novara stavano dunque soldati svizzeri: assedianti e assediati. La Dieta, informata della situazione, mandò esortazioni, ordini di ritornare in patria, di evitare la lotta fratricida. Finalmente, i mercenari delle due parti s’intesero: quelli di Re Luigi avrebbero lasciato uscire da Novara i soldati del Moro senza molestarli. Ma tra le colonne che sfilavano s’inserì Lodovico, travestito da svizzero, e un ufficiale dell’altra parte lo riconobbe e lo additò ai Francesi; il Moro fu catturato e portato a finire la vita prigioniero in Francia; il “tradimento di Novara” gettò un’ombra funesta sugli Svizzeri, anche se il traditore, richiamato dal suo governo, venne processato e giustiziato sulla piazza di Altdorf.
Nel frattempo, che cosa avveniva a Bellinzona? La borgata dei Tre castelli, detti originariamente di San Michele, di Montebello e di Sasso Corbaro, era rimasta fedele al suo Duca, quindi aveva accolto i Francesi quali nemici; a un certo punto, anzi, era insorta contro il nuovo presidio mettendolo in fuga. Al momento di Novara, tuttavia, sentendosi senza più protezione ed esposta anzi a rappresaglie nel caso che i Francesi fossero tornati, essa richiese l’aiuto degli Svizzeri e stipulò con i Tre Cantoni primitivi il cosiddetto atto di “dedizione volontaria”; con esso, si affidava a Uri, Svitto e Unterwalden – che allora diedero il loro nome ai castelli – come a protettori e alleati; per ricordo durevole del nuovo destino della Turrita, i Tre Cantoni fecero coniare un grosso d’argento nella zecca di Bellinzona, con data del 1505 e il motto orgoglioso attribuito a Bellinzonesi e Confederati: “In libertate sumus”. La dedizione di Bellinzona avvenne nell’aprile del 1500; la data incisa sulla moneta rammenta la pace di Arona (1505) tra il Re di Francia e gli Svizzeri, nella quale la Turrita veniva riconosciuta agli Svizzeri.
Così, dopo poco più di cent’anni di politica gottardista, tutto il corso superiore del Ticino, fino alle porte di Locarno, era in potere di quei Confederati che avevano fondato la Svizzera.
Nella tarda estate di quello stesso 1505, la Dieta calcolò che le perdite dei mercenari sommassero negli ultimi anni a oltre trentamila uomini; il vescovo di Sion denunciò gli abusi di quei soldati di ventura e i mali che ne venivano al paese, primo fra tutti la scomparsa del senso della disciplina e dell’onore. Quanti lutti si sarebbero potuti evitare, avessero avuto i capi un bricciolo di saggezza politica e di moderazione! Con un “proclama circa le pensioni” la Dieta ordinò che nessuno nella Confederazione potesse concludere accordi con l’estero senza il consenso della maggioranza degli Stati svizzeri; in egual tempo, venne proibito ai singoli di accettare regali dall’estero. L’accordo sarebbe dovuto essere rinnovato e giurato ogni anno, e se un Cantone si fosse rifiutato sarebbe stato tenuto “in attesa fuor della porta”, cioè escluso dalla Dieta. Belle parole … Ma ormai più nulla, di fronte alle nuove generazioni ch’erano state corrotte dall’esempio degli anziani, più nulla poteva trattenere la corsa all’arruolamento. Già pochi mesi dopo la sua pubblicazione, il “proclama sulle pensioni” era dimenticato; con amarezza notava uno scriba glaronese che, benché inserito nelle leggi della Confederazione, non “era mai contato gran che …”.
Nuove potenze intanto entravano nel gioco politico che aveva per posta la Penisola. Il Regno di Spagna anzitutto, che dieci anni prima aveva cacciato gli Arabi e s’era rafforzato in unità nazionale, e che – con la scoperta dell’America compiuta da Cristoforo Colombo per suo conto – stava divenendo una potenza di prim’ordine, padrona di terre e di oceani, beneficiaria di nuove, immense ricchezze. Dall’Adriatico, attraverso i suoi domini di terraferma tornava ad affacciarsi sull’Italia la politica di Venezia, accorta politica sorretta dalla forza d’importanti eserciti. Negli Stati del Papa grandeggiava la figura del nuovo Pontefice Giulio II° della Rovere, temperamento intrepido di uomo politico e di guerriero, e protettore a un tempo dei più geniali artisti dell’epoca; basti pensare che nei primi anni del Cinquecento lavoravano contemporaneamente per lui Bramante, Raffaello e Michelangelo … Fu Giulio a circondarsi della “Guardia svizzera” e a concedere agli Svizzeri ogni sorta di favori e di onori, per averli ligi alla sua politica. Dal Trentino si avvertivano le ambizioni e i preparativi di Massimiliano; l’imperatore asburgico doveva riscattarsi dall’onta di aver abbandonato al suo triste destino Lodovico Sforza; si sentiva in dovere d’assistere i due giovani figli del Moro rimettendoli nella città dei loro padri; incoraggiato dai parenti vicini e lontani pensava di ridare credito alla sua corona mediante un viaggio sino a Roma e l’incoronazione in San Pietro, quale titolare dell’Impero romano e germanico (dovette, purtroppo, rinunciare al viaggio solenne e contentarsi di un’incoronazione fatta a Trento, e nemmeno per opera del Papa, ma soltanto di un suo Legato …).
Massimiliano cominciò dunque con una clamorosa assise imperiale a Costanza; nella città di confine anche gli Svizzeri vennero invitati e si lasciarono facilmente strappare la promessa di seimila mercenari che accompagnassero l’Imperatore sino alla Città eterna. Il Re di Francia, allora, smanioso d’impedire il nuovo orientamento asburgico dei Cantoni, mise in opera tutte le arti delle lusinghe diplomatiche e del denaro; il cronista bernese Anshelm, in buona posizione per osservare il gioco dei Francesi, scrisse che il Re gettò oro a piene mani e in tutte le direzioni: “A uomini, donne, ragazzi, servitori, vivandiere, prostitute, per le strade e nei vicoli, nelle città e nei villaggi, nei bagni pubblici e nelle osterie, in occasione dei riti in chiesa e dei settimanali mercati in piazza, dalle bettole fin su alle sedi delle corporazioni …, dovunque potesse arrivare l’ambasciatore della Francia”.
Giulio II° non pensò neppure un istante di riconoscere all’Imperatore il dominio dell’Italia. Più che i progetti di Massimiliano, lo interessava il modo di cacciare gli stranieri dalla Penisola; stranieri e però barbari erano tutti, Francesi, Tedeschi, Spagnoli. “Fuori i barbari!” fu il suo grido, caratteristico anch’esso del Rinascimento: un rinascimento politico che completasse quello della cultura. La potenza guerriera degli Svizzeri dovette sembrargli il mezzo migliore all’impresa, e l’uomo migliore il vescovo di Sion, Matteo Schiner. Figlio di poverissima gente, ex pastore di capre, lo Schiner aveva studiato nel Seminario di Como e ricevuto gli ordini e la consacrazione episcopale a Roma. Mentre la maggior parte dei capi svizzeri, senza idee chiare, pencolavano tra Francia e Impero, egli sapeva esattamente la sua linea politica; era, come già detto, antifrancese, in quanto la Francia – venisse da sud o da nord – poteva essere un pericolo per la sua Valle del Rodano e per la personale sua posizione di Principe e di Vescovo.
Come spesso i capi usciti dall’umile plebe, era orgogliosissimo, ma egualmente austero e incorruttibile; al popolo e al clero offrì sempre l’esempio d’una vita severa, senza alcun lusso, dominata da uno spirito che si conservò uguale nella capanna del pastore e nel palazzo del Principe-vescovo; se profuse denaro e comprò soldati, lo fece perché conosceva quella che egli stesso definì “la malattia nazionale degli Svizzeri”, ma in pari tempo denunciò e combatté con la sua fiera eloquenza ogni compromesso politico determinato dall’oro e dai donativi degli stranieri. Animato e addirittura ossessionato dall’idea della preminenza di papato e Impero (si è tentati di dire “idea dantesca”), fu il migliore avvocato di Papa Giulio, al quale del resto per carattere somigliava.
Fina dal suo primo incontro con Giulio II°, lo Schiner tornò ai suoi monti quale Nunzio del Pontefice; un anno e mezzo più tardi, ricevette la porpora di Cardinale, anche per il merito di aver saputo concludere un’alleanza politica tra il Papa e gli Svizzeri.
Ora, il Papa poteva avviare l’impresa della liberazione: “cacciare i barbari servendosi di altri barbari”. Per prima cosa, creò la “Lega santa” (1511) nella quale entrarono la Spagna, Venezia, l’Inghilterra, l’Impero, e alla quale i Cantoni svizzeri avevano assicurato un contributo militare di seimila soldati.
Essi costituivano del resto il solo elemento guerresco di qualche peso, ché gli eserciti della Lega santa erano stati duramente sconfitti a Ravenna (1512) dal giovane condottiero dei Francesi, Gastone di Foix; un brutale rovescio militare per il papa che, chiuso in Castel Santangelo, temette di veder comparire d’un tratto i nemici sotto le mura di Roma.
Ma i Francesi non seppero sfruttare la vittoria, e il loro giovane capitano venne anzi circondato dagli Spagnoli, che inseguiva, e ucciso.
Intanto, per i passi delle Alpi, accorrevano messaggeri verso i cantoni a sollecitare aiuti; non si trattava più di “capitolazioni” cioè di mercenari; si trattava di “proteggere la santa Chiesa”, questa era la nuova parola d’ordine, contro il Re di Francia; un impegno politico, dunque, che toccava gli Svizzeri come per cosa propria.
La loro ostilità alla Francia era del resto cresciuta per un malaugurato incidente: alcuni messi dei paesi di Svitto, di Berna e di Friburgo, malgrado tenessero bene in mostra gli stemmi cantonali, erano stati catturati dai Francesi a Lugano e annegati senza misericordia.
Sullo scorcio del 1511 si registreranno discese di eserciti in Italia, ritornati senza aver combattuto oppure richiamati dalla Dieta federale.
Fu nell’aprile del 1512, all’incirca durante le giornate di Ravenna, che la Dieta decise la grande spedizione in Lombardia.
L’impresa di Pavia, 1512
Prima della grande spedizione di Pavia, i Confederati avevano iniziato due campagne che riuscirono disgraziate e vergognose; basterà farne qui un rapido cenno.
Nell’alleanza conclusa tra gli Svizzeri e la Santa Sede, auspice il vescovo di Sion, i primi s’erano impegnati a fornire seimila uomini a Giulio II°, onde combattere i nemici della Chiesa, identificati in quel momento nei Veneziani.
Nel 1510 si ebbe la rottura aperta tra il Pontefice e il Re di Francia, mentre Venezia veniva guadagnata alla causa di Roma, e quando l’attacco generale contro i Francesi fu pronto, lo Schiner domandò i seimila soldati previsti dalla capitolazione.
Cominciò allora in ogni Cantone il più intenso lavorio diplomatico, svolto dal Re di Francia e dall’Imperatore, ma in modo particolare dal primo e con straordinaria abilità; fu una strategia di corruzione e di esaurimento, cui corrispondeva l’impreparazione militare e finanziaria del partito papale, che ebbe come prima conseguenza di ritardare di due mesi l’arrivo degli Svizzeri sui campi di Lombardia.
Lo svolgimento della guerra nell’alta Italia riuscì pertanto vantaggioso a Luigi XII° che stava rioccupando la Lombardia, e gli Svizzeri presero la via del ritorno (settembre 1510); questa infelice spedizione si chiamò “di Chiasso”.
Da ciò, sdegno del Papa, irritazione della Dieta contro Giulio II°, risentimento di tutti contro lo Schiner, rivolta della “decànie” superiori del Vallese, ribelli al loro Principe-vescovo, e fuga dello Schiner a Roma, dove gli riuscì di calmare il Pontefice, ottenendo il cappello cardinalizio e l’incarico di nuove trattative con gli Svizzeri.
Il Re di Francia soffiava nel fuoco, ché l’alleanza con gli Svizzeri avrebbe potuto consentirgli la conquista dell’intera Europa; dice con la consueta sua intuizione il Guicciardini: “… Ma niuna cosa più premeva al Re di Francia che il desiderio di riconciliarsi gli Svizzeri, conoscendo da questo dipendere la vittoria certissima, per l’autorità grandissima che aveva allora quella nazione, per il terrore delle loro armi, e perché pareva che avessino cominciato a reggersi non più come soldati mercenari né come pastori, ma vigilando, come in repubblica bene ordinata, e come uomini uniti nell’amministrazione degli Stati …” (“Storia d’Italia”, vol. III, libro VII). Le trattative di Luigi fallirono tuttavia un’altra volta e ciò sopra tutto per l’irriducibile opposizione dei Cantoni primitivi.
Questa opposizione si andava estendendo anche ai Confederati del nord e dell’occidente, con una sorda irritazione del popolo verso ciò che fosse francese e lombardo, e crebbe in modo inaspettato quando si seppe dell’uccisione, avvenuta per opera della guarnigione francese di Lugano, dei messaggeri di Friburgo, Berna e Svitto.
Così, verso la metà del 1511, la Confederazione fu di nuovo in guerra contro la Francia.
Si tratta della “fredda campagna invernale” – novembre e dicembre – che culminò in un disastro.
I Francesi usarono con astuzia la loro strategia di spossamento, attirarono gli Svizzeri nella pianura per rifugiarsi poi nelle piazzeforti; gli alleati papali e veneziani non si lasciarono vedere; i viveri cominciarono a mancare, e allora i Confederati si abbandonarono a rapine, incendi e violenze d’ogni sorta; finalmente, fu la ritirata disordinata e furibonda.
Ora, tornava alla ribalta Matteo Schiner; malgrado la vittoria di Gastone de Foix, il lunedì di pasqua del 1512, gli Svizzeri rafforzarono l’alleanza col Papa.
Per la prima volta, in molti anni, in tutto il territorio della Confederazione ci fu unità di propositi, dal governo delle Città ai montanari delle più remote vallate, in ogni ambiente e in ogni classe; se ne trova un’eco in una missiva del cappellano glaronese Ulrico Zwingli: “I Confederati ritengono che non è lecito a ogni tiranno furioso di assalire impunemente la Madre comune dei cristiani.
Essi … intendono ristabilire per il meglio le cose della Chiesa e dell’Italia”. Diciottomila soldati furono arruolati in breve tempo, dai passi dei Grigioni condotti in Italia e concentrati a Verona, consenziente la Repubblica di Venezia che s’era alleata agli Svizzeri.
Da Verona partì dunque la spedizione di Pavia che in poco più di tre settimane spazzò via i Francesi dall’Italia.
Mai s’era visto un più grande esercito di Svizzeri, né mai tanto animoso e concorde; protetto alle spalle dai Veneziani, si spinse deciso verso occidente; dove, come sull’Adda, mancavano i ponti, i soldati si gettarono a nuoto reggendo sul capo l’alabarda e cacciando i nemici che tentavano d’impedire la formazione di teste di ponte.
In tutte le contrade di Lombardia risuonò il grido di gioia della liberazione: “Giulio! Gli Svizzeri son vincitori!”.
Ulrico Zwingli scriveva esultando: “Grazie agli Svizzeri, tutta l’Italia, le coste liguri e la Lombardia sono ora libere”; Niccolò Machiavelli, che stava in quel momento componendo “Il Principe”, definiva gli Svizzeri “armatissimi e liberissimi”; letterati di Lombardia scrivevano: “Nelle come nelle borgate e nei villaggi echeggiano le trombe, squillano le campane”.
Dotti, religiosi e predicatori esclamano dai pulpiti: “Voi siete il popolo di Dio, voi avete umiliato i nemici della sposa di Cristo!”; il Papa saluta i Confederati quali “Difensori della libertà della Chiesa” e manda loro quelle preziose bandiere che ancora oggi si possono ammirare nei musei della patria; al barone Ulrico di Hohensax, che quale pupillo di Hans Waldmann era anche borghese di Zurigo, inviò in dono una preziosa spada gemmata.
E qualcuno comincia a pensare che l’unica salvezza dell’Italia contro i Tedeschi, gli Spagnoli, i Francesi sia l’unione con gli Svizzeri.
Tre anni di potenza
Tutto l’arco alpino, dal Monte Bianco allo Stelvio, era controllato dagli Svizzeri; le sorti del Ducato stavano nelle mani dei Cantoni.
Questa volta, essi non si contentarono di lodi e di donativi, ma cominciarono a occupare le terre che più gli interessavano; così Locarno (sulla bocca degli Svizzeri, (Luggarus) e Lugano (Lauis), Mendrisio (Mendris) e la Valle Maggia (Meiental), l’Ossola (Thum) da una parte, e Bormio, la Valtellina e Chiavenna (Klaven) dall’altra divennero proprietà degli Svizzeri. A occidente, Berna, Friburgo e Soletta si spinsero su Neuchatel che era nelle mani di un Principe francese, Soletta s’impadronì della valle della Birsa, Berna fece preparativi per invadere addirittura la Borgogna.
Alla Dieta di baden, sul finire dell’estate, affluirono i rappresentanti di tutte le potenze dell’Europa, a gara nel conquistarsi il favore e l’alleanza degli Svizzeri: Papa, Imperatore, Re di Spagna, Doge di Venezia, Duchi di Milano, di Savoia, della Lorena e altri signori erano rappresentati sulle rive della Limmat da schiere fastose di ambasciatori e di cortigiani; la Lega dei montanari non era forse divenuta una terribile potenza? Chi poteva impedirle di assumere ora una parte di prim’ordine nel determinare l’assetto dell’Europa? “Non esisteva potenza straniera che potesse rovesciarla o distruggerla”, così commentava il cronista bernese Anshelm.
Il ricordo del tradimento fatto al Moro dodici anni avanti da uno Svizzero turbava ancora le coscienze dei capi; anche per doverosa riparazione, la Dieta decise di consegnare Milano al giovane Massimiliano Sforza, che sarebbe dovuto diventare un docile strumento della politica gottardista degli Svizzeri e che, per parte sua, s’impegnava di meritare la protezione elvetica mediante un dono di centocinquanta mila ducati e un contributo annuo di altri 40 mila; il Ducato di Milano diveniva pertanto un “protettorato” degli Svizzeri. A Milano, il 29 dicembre del 1512, i delegati della Dieta consegnarono solennemente le chiavi della città al figlio del Moro, mentre il Landammano di Zugo, Giovanni Schwarzmurer, leggeva un ornato discorso in latino e in “lombardo”. Da parte sua, il Duca nominava il cardinale Schiner marchese di Vigevano e il Papa lo faceva vescovo di Novara; così il condottiero vallesano assumeva un’importanza politica decisiva nelle faccende dell’alta Italia; il suo successo fu turbato soltanto – fra tanti onori – dalla morte del grande amico, Giulio II°, al quale succedette un Medici, il cardinale e umanista Giovanni che prese il nome di Leone X.
Ma c’era qualcuno che non considerava chiusa la partita in Lombardia: Re Luigi di Francia.
Nei primi mesi del 1513, che i passi alpini coperti di neve trattenevano ancora gli Svizzeri nelle loro contrade, era riuscito al Re di far passare un esercito nella Penisola e di riprendere parte della Lombardia. Gli era anche riuscito di staccare Venezia dalla Lega santa e di farsela un’altra volta alleata. Comandavano l’esercito francese, forte di ventidue mila uomini, i marescialli Trivulzio e La Trémouille che sorpresero lo Sforza e lo chiusero dentro Novara con i suoi quattromila mercenari.
Novara, un’altra volta. La “seconda” Novara. Ma questa volta aureolata di gloria militare. Tra le schiere del Re di Francia, numerosa e gagliarda quella dei mercenari tedeschi, i famosi lanzichenecchi, ché il Re aveva cominciato ad assoldare lanzi in Germania e questo era un motivo, oltre il rifiuto d’accrescere le paghe, di acerbo rancore da parte degli Svizzeri i quali vedevano arrivare concorrenti nella milizia venale e nella fama bellica a cui tenevano non meno che al denaro. Le truppe del Re avevano dunque dato un primo assalto e infranto le mura in un punto con le loro artiglierie, aprendovi una gran breccia che gli Svizzeri sprezzantemente non avevano neppure riparato, limitandosi a tendere dei teli per nascondere i loro movimenti; gli assedianti non avevano però osato l’assalto, anzi s’erano ritirati e accampati all’Ariotta, un cascinale a qualche chilometro dalla città.
Sapevano che una parte dei mercenari elvetici, chiamati dal Duca Massimiliano e da Papa Leone, erano chiusi in Novara, che un’altra parte stava sopraggiungendo a gran marce, dal Grimsel e dal Sempione, e non volevano essere presi tra due fuochi. Con gli assediati, poco più di quattromila uomini, era quel Giacomo Mottino, capitano di Uri ma d’origine leventinese, del quale la tradizione accolta da alcuni storici del tempo e letterariamente ampliata dal Guicciardini fece l’eroe della giornata. Racconta lo storico fiorentino che il Mottino, dopo aver esortato i suoi uomini con feroce e ardentissimo spirito) il Giovio attribuisce invece l’appello a un “mastro Graf” di Zurigo), senza attendere nemmeno il primo chiarore dell’alba guidò la sortita degli Svizzeri e la sorpresa contro il campo francese.
A gran passi, malgrado il fulminare delle artiglierie nemiche, i fanti svizzeri avanzarono verso l’Ariotta, incuranti dei vuoti aperti nelle loro file dal fuoco francese, poi si azzuffarono con i lanzi tedeschi – tremendo combattimento, dunque, tra tedeschi di Germania e tedeschi di Svizzera – dei quali fecero strage; la cavalleria francese, ritardata dal terreno acquitrinoso, non poté efficacemente intervenire. Dopo sei ore, i Francesi erano sbaragliati e messi in fuga fino alla Alpi, fuga resa più tragica dalla ferocia dei contadini che si appostavano sulle strade, per uccidere e spogliare i dispersi. Francesco Guicciardini, nell’undicesimo libro della sua “Storia d’Italia”, commenta con ammirato stupore: “Non fece mai la nazione de’ Svizzeri né la più superba né la più feroce deliberazione. Pochi contro a molti, senza cavalli e senza artiglierie, e contro ad un esercito potentissimo di queste cose, non indotti da alcuna necessità … elessero spontaneamente di tentare piuttosto quella via nella quale la sicurtà fosse minore ma la speranza della gloria maggiore, che quella nella quale dalla sicurtà maggiore resultasse gloria minore”.
Il 6 giugno 1513, a Novara, il Re perdette circa settemila uomini, fra cui la quasi totalità dei lanzi, ma anche gli Svizzeri lamentarono le più gravi perdite di tutte le battaglie combattute fino allora – oltre duemila soldati -, tra esse quella del Mottino, trafitto “mentre combatteva, nella gola da una picca”. L’Italia era di nuovo liberata dai Francesi, il Duca Massimiliano tornava a Milano rinnovando ai Confederati le più commosse attestazioni di amicizia (!Quanto mi avete conservato, anzi reso col vostro valore e con il vostro sangue, deve ormai appartenere a voi come me stesso”), i Bernesi annunciavano che “con l’aiuto di Dio potremmo ormai percorrere la Francia in tutti i sensi”, nelle corti d’Italia e in ispecie a Roma la retorica degli umanisti innalzava lodi ai vincitori, facendo confronti – in favore degli Svizzeri – tra l’episodio di Novara e le più famose battaglie dell’antichità, la Lega santa riprendeva vigore, malgrado l’indecisione e l’ambiguità di Leone X che, uomo di cultura e di arte, non aveva certamente l’istinto politico e la fierezza del suo predecessore.
In quelle settimane di generale euforia, soltanto l’ambasciatore fiorentino Francesco Vettori vedeva con qualche chiarezza davanti a sé; pur ammirando grandemente il valore degli Svizzeri e la loro fedeltà, anche se mercenari, riteneva ch’essi fossero incapaci di dare ordine e di amministrare un grande popolo (l’italiano) e ciò per lo stesso frazionamento e il particolarismo delle loro minuscole Repubbliche. L’infelice Massimiliano non poteva in quel momento supporre che, soltanto due anni più tardi, la fortuna gli avrebbe voltato le spalle, e che egli si sarebbe rassegnato ad andare a vivere a Parigi con una pensione del Re Francesco I°, sentendosi finalmente e malinconicamente “libero dalla tirannide degli Svizzeri, dalle frodi degli Spagnoli, dalle vessazioni dell’Imperatore”.
L’esaltazione del successo di Novara si propagò alla Confederazione, nel suo interno; nuove spedizioni vennero progettate e messe in moto. Disgraziatamente, molti vecchi Capitani del Re di Francia e agenti insidiosi erano riusciti e riuscivano tuttavia a condurre sotto le bandiere francesi nuovi mercenari, sedotti e comprati, così che ancora una volta venivano a trovarsi di fronte, in avversi campi, i figli della stessa terra. L’autorità tardò a reagire; il risultato cocente fu una serie funesta di rivolte delle campagne contro la doppiezza e gl’intrighi dei governi cittadini, con episodi clamorosi di processi popolari e di esecuzioni sommarie. Berna, Lucerna, Soletta vennero percorse ripetutamente dal furore delle plebi.
Finalmente, nell’autunno del 1513, guidate dai Bernesi le schiere confederate invasero la Borgogna per quella che si rammenta quale Guerra di Digione; la città, sotto le cui mura gl’invasori erano rapidamente arrivati, non poteva difendersi e allora il La Trémouille, governatore della Borgogna, giocò di astuzia avviando di sua propria autorità trattative di pace; le basi di esse consistevano nel riconoscimento del protettorato svizzero su Milano, Cremona e Asti, in una più rigorosa regolamentazione degli arruolamenti futuri in favore della Francia e nel pagamento di un’indennità di quattrocento mila corone da parte del Re. I Confederati commisero l’errore di accettare e di ritirarsi senza garanzie effettive che gli accordi con il governatore sarebbero stati rispettati; infatti, il Re non li accettò, dichiarando “estorto” il trattato di Digione. Agli Svizzeri delusi non restò quindi che continuare la guerra, mentre il popolo accusava sempre meno velatamente i capi militari di essersi lasciati comperare dall’oro del La Trémouille.
La ritirata dalla Borgogna fu precipitosa, accompagnata da episodi gravissimi di indisciplina e – in ragione della prosperità della celebrata zona vinicola – punteggiata da infami saccheggi. La rapidità della ritirata permise tuttavia in qualche modo ai Confederati di salvare la faccia.
La battaglia di Marignano, 13/14 settembre 1515
Avessero insistito nell’assedio di Digione, i Confederati non sarebbero stati giocati da Luigi XII° che, in quel momento, si trovava davvero in un vicolo cieco: la Francia invasa da due parti, dagli Svizzeri e dagli Inglesi, l’esercito disorientato, i capi militari discordi … Quando, tuttavia, entrambi gl’invasori si furono ritirati, il Re riprese a carezzare quel che fu il sogno di tutta la sua vita: l’annessione della Lombardia. Ma i suoi rinnovati preparativi vennero troncati dalla morte, il Capodanno del 1515. Gli succedette sul trono il ventenne Francesco I°, colui che sarebbe stato il grande, brillante, glorioso Re di Leonardo da Vinci (che onorò e ospitò in Francia negli ultimi anni di vita del prodigioso artista) e ad un tempo l’infelice protagonista del duello tra Francia e Spagna, impegnate entrambe nella conquista dell’Italia. Francesco riuscì anzitutto ad attirare Venezia dalla sua parte, per modo di poter prendere la Lombardia in una tenaglia. La defezione della Serenissima dalla Lega santa incitò il cardinale Schiner a raddoppiare gli sforzi per consolidare l’alleanza che comprendeva, ora, gli Svizzeri, l’Imperatore, il Duca di Milano, la Spagna e il Pontefice.
A Lione venne concentrata la forza francese; si trattava del più bell’esercito che fosse mai stato messo su piede di guerra: cinquantacinque mila uomini, dei quali quindici mila a cavallo, settanta pezzi di artiglieria pesante e trecento cannoncini trasportabili a dorso di mulo; con stupore si poteva poi notare che l’Imperatore, malgrado l’alleanza con il papa, aveva consentito alla Francia di assoldare mercenari sulle sue terre, circa seimila lanzi chiamati “Bande nere” dal colore delle armature e delle bandiere. Quale direzione avrebbe preso il formidabile esercito? Il Giura, con la conseguente invasione della Confederazione? La pianura del Po? Se lo chiesero per primi e ansiosamente i capitani degli Svizzeri che provvidero a rafforzare le loro cittadelle fortificate verso la Francia e a guarnire i passi tra il Monte Bianco e gli sbocchi verso la pianura, a Susa, Pinerolo, Saluzzo. Ma il Re li giocò abilmente: mandò piccoli contingenti verso i passi più noti e che gli Svizzeri presidiavano, mentre con il grosso dell’esercito in cinque giorni di marce forzate valicava l’Argentera e giungeva a Cuneo, la sua artiglieria pesante veniva trasportata in Italia attraverso il Monginevro, quindi Fenestrelle e Torino. I Francesi erano di nuovo in Italia!.
Francesco aveva cercato di riconciliarsi con gli Svizzeri, mediante denaro e pensioni, ma senza rinunciare a Milano né riconoscere il trattato di Digione. Impossibile, dunque, un’intesa; inevitabile il ricorso alle armi. I Confederati ebbero una volta di più l’impressione di essere beffati e sprezzati dal Re di Francia, dalla malafede e dall’arroganza dei Francesi; da ciò, l’odio contro quella nazione. Venezia era considerata un altro covo di astuzie e di perfidia; l’Imperatore consentiva al nemico di arruolare soldati tra i suoi uomini; Leone X si barcamenava tra la Lega e Francesco, preoccupandosi piuttosto di ingrandire la potenza della sua famiglia che non di dare direttive energiche all’esercito pontificio; soltanto gli Spagnoli erano in armi, sul confine tra Milano e Venezia. Gli Svizzeri si sentirono ancora una volta abbandonati.
Per maggior disgrazia, la discordia entrò anche nelle loro file; i Cantoni gottardisti decisero di rinunciare al Piemonte e di ritirarsi nella Lombardia, alla difesa di Milano, cioè di scegliere la tattica del combattimento in aperta campagna, mentre i Bernesi volevano tenere le montagne, persuasi che con minor numero di uomini si potesse produrre al nemico un guasto maggiore; proponevano inoltre di mandare un contingente armato in Savoia, prendendo così i Francesi alle spalle; avvertivano finalmente che, in caso di rifiuto delle loro proposte, le truppe di Berna sarebbero rincasate per la via più breve; proposte e propositi militarmente intelligenti, politicamente disgraziati … Prevalse il parere dei Cantoni centrali, i Bernesi dovettero rinunciare alle postazioni lungo i piedi delle Alpi, il duca di Savoia cominciò a fare opera di mediazione per un incontro bonale tra il Re e i capi elvetici.
Gli Svizzeri si ritirarono su Vercelli, poi su Novara e Milano; avevano rinunciato a difendere il Piemonte, avevano mancato l’occasione di impedire, almeno, la congiunzione delle truppe, della cavalleria e dell’artiglieria dei nemici; erano in più irritati perché non arrivava il soldo della Lega, né le campagne lombarde, stremate da tante guerre e devastazioni, potevano offrire occasione a rinnovati saccheggi. Tra qualche episodio di ammutinamento, le truppe dei Cantoni cittadini ripiegarono su Arona, lungo il Lago Maggiore, di dove molti soldati, per mancanza di denaro e per la crescente miseria, partirono verso i loro paesi d’origine. I Cantoni montanari, invece, si stabilirono tra Milano, Varese e Sesto Calende.
Si diffondeva tra gli Elvetici un pericoloso sentimento di rassegnazione, la convinzione dell’insuccesso e una sorta di represso furore; soltanto Uri, Svitto e Glarona, più tardi anche Lucerna, sembravano decisi a tutto, poi che rappresentavano le costanti di una tradizione gottardista; il Re, informato regolarmente di tutto, intensificò le trattative e poté finalmente incontrare, a Gallarate (8 e 9 settembre) i comandanti elvetici, Ne uscì il nefasto “Trattato di Gallarate” con il quale Francesco accettava di pagare le quattrocento mila corone previste nell’armistizio di Digione, più altre trecento mila che il Duca di Milano non era mai riuscito a mettere insieme, malgrado le sue nuove imposte; gli Svizzeri, però, rinunciavano alle conquiste fatte con la spedizione di Pavia e alla protezione di Massimiliano, al quale il Re accordò un nuovo ducato in Francia e la mano di una nobildonna francese.
Peggio: i Bernesi e il loro partito si dissero pronti, per altre trecento mila corone, a sgombrare anche le terre ticinesi, la Val d’Ossola e la Valtellina, annullando così d’un tratto i risultati secolari della politica transalpina dei Cantoni posti sotto il San Gottardo. Gli antagonismi, egualmente secolari, tra città e montagne e la natura dei patti di alleanza dei nuovi arrivati con i Cantoni forestali spiegano ampiamente tanto la mentalità dei capi responsabili, quanto le vergognose concessioni di Gallarate.
Berna e le città sue amiche, con il pretesto della validità del trattato gallaratese, rimpatriarono i loro contingenti.
In Lombardia rimasero soltanto i gottardisti, più gli Zurigani condotti dal fiero e incorruttibile Marco Röist, discesi in Italia per ordine della Dieta; pieni di sdegno e di furore erano i rimasti, offesi dalla condotta dei Bernesi, esasperati per l’abilità di Francesco I°, memori più che mai di una politica transalpina che era costata sacrifici immensi a tante generazioni della loro gente; per essi, la Lombardia era conquista legittima, andava quindi difesa una volta ancora. Ricevuti rinforzi, il 10 settembre entrarono in massa a Milano.
Persino entro la città divamparono una volta ancora le discordie a proposito dell’opportunità di accettare o meno le decisioni di Gallarate; fu il cardinale Schiner a comporre quelle ultime discordie; persuase Zurigani e soldati di Zugo – già pronti a rimpatriare – a unirsi agli altri; mise in opera la sua singolare eloquenza, ma anche la sua astuzia divulgando notizie inesatte o esagerate; riuscì a far tacere i risentimenti interni e le discordie fratricide, orientando rancore odio e furore in una sola direzione, cioè contro i Francesi, e facendo un fascio di ragioni politiche e religiose, di prestigio, di gloria e di potenza. La battaglia che si preparava sarebbe stata così davvero una lotta “nazionale”: una parte della nazione degli Svizzeri contro la schiacciante potenza della nazione dei Francesi. Non più, finalmente, una zuffa di mercenari.
Francesco I° era giunto a sud-ovest di Milano, s’era accampato a Marignano, dove provvedeva a fortificarsi con trincee, fossati e palizzate; era il terreno, presso il villaggio di Zivido, sul quale nell’antichità i Romani avevano costituito una loro colonia. Il Re disponeva di circa quaranta mila uomini, più altri venti mila che tenevano i territori occupati, di una cavalleria mobilissima e di una potente artiglieria; attendeva inoltre, di giorno in giorno, l’arrivo degli alleati veneziani. Gli Svizzeri erano venti mila, non potendo contare né sugli Spagnoli né sulle truppe pontificie-fiorentine. Tre volte più numerosi i nemici, dunque, e molto meglio armati; se la battaglia di Novara era stata, si può ben dire, l’ultima del medio Evo, questa che s’annunciava era la prima dell’età moderna, grazie appunto all’arma moderna e decisiva: l’artiglieria.
Le prime scaramucce si ebbero il pomeriggio del 13 settembre, mentre i capi militari stavano riuniti in consiglio nel Castello sforzesco; il cuoiaio zurigano Rodolfo Rahn allarmò tutti con la notizia che si stava già combattendo sotto le mura di Milano; Francesco aveva mandato un corpo di cavalleria in esplorazione verso la città e contro di esso s’erano subito avventati gli Svizzeri. All’allarme rispose per primo il cardinale Schiner; sapeva che il miglior mezzo per trascinare in combattimento gli esitanti – i capi di Zurigo e di Zugo, in particolare – consisteva nello scatenare la battaglia: essa avrebbe travolto tutti nel suo impeto fatale. Balzato a cavallo, il cardinale fu tra i primi a slanciarsi fuori di Porta Romana – la sua porpora splendeva al sole come una bandiera di sangue – tosto seguito dai Cantoni primitivi e dai Glaronesi. Gli Svizzeri si accorsero immediatamente che si trattava in fondo di uno scontro tra avamposti, i capitani pensarono che sarebbe stato più prudente rinviare la lotta al mattino seguente, ma ormai la febbre del combattimento li aveva travolti; chi poteva arrestare le schiere che marciavano in avanti, verso Lodi, in assetto di battaglia, incalzate dalla logica appassionata della morte?
L’esercito del Re stava su tre linee, tra Milano, Lodi e il corso della Roggia Nuova che è un braccio naturale del Lambro; nel triangolo tra la strada, Santa Brera e Zivido c’era anzitutto l’avanguardia, comandata dal Connestabile di Borbone che l’aveva allineata verso Milano, a San Giuliano; il corpo centrale o massa d’urto era intorno a Santa Brera agli ordini dello stesso Re; la retroguardia, comandata dall’Alençon, stava indietro, verso Marignano; per le fortificazioni e i trinceramenti erano stati utilizzati numerosi corsi d’acqua, le paludi, i canali d’irrigazione. Gli Svizzeri marciavano dunque in disordine sullo stradale di Lodi; nelle vicinanze di San Donato, ripiegarono nella campagna; la sera s’avvicinava, sarebbe stato conveniente rinviare lo scontro, ma come trattenere la massa ormai lanciata?
 Il cardinale Matteo Schiner di Sion,legato papale in Lombardia,
Il cardinale Matteo Schiner di Sion,legato papale in Lombardia,
percorre a cavallo il campo di battaglia di Marignano incitando le truppe al combattimento
Di fronte al nemico, i Confederati si ordinarono finalmente in tre corpi, tenendo al centro il borgomastro di Zurigo, Marco Röist, che dirigeva il grosso delle truppe. Come sempre, prima d’ogni battaglia, essi s’inginocchiarono per una breve preghiera; il condottiero Werner Steiner di Zugo raccolse per tre volte una manciata di terra e ne asperse i morituri con la formula tradizionale: “Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, questo sarà il nostro cimitero!”; risuonava intanto feroce il grido di guerra dei cantoni forestali, lugubremente punteggiato dai corni delle Alpi e dalle cannonate dei Francesi, e in quello spaventoso clamore i Confederati si buttarono sul nemico.
L’artiglieria apriva vuoti paurosi nelle loro file, ma essi ritennero, come a Novara, di poter raggiungere i cannoni, impegnare il corpo a corpo e rivolgere l’armi terribili contro l’avversario; tuttavia, le cose andarono diversamente, poi che il Trivulzio e il duca di Borbone investirono di fianco gli Svizzeri con la cavalleria pesante; questi ultimi riuscirono ancora una volta ad averne ragione, sbaragliando così l’avanguardia francese e inseguendola.
Si giunse allora allo scontro tra le due masse centrali, in particolare tra gli Svizzeri e i Lanzi tedeschi delle bande nere, che i Confederati odiavano a morte (la cronaca riporta episodi inauditi di crudeltà, da una parte e dall’altra, che conferma siffatto odio bestiale …); la battaglia durò sino a notte, continuò furiosa al chiarore della luna fin verso la mezzanotte, quando la fosca luna di settembre si velò sulla carneficina.
In complesso, la prima fase della lotta era stata favorevole agli Svizzeri: l’avanguardia francese disfatta, il grosso costretto ad indietreggiare, dodici pezzi d’artiglieria e molte bandiere si trovavano ora nelle mani dei Confederati.
Il resto della notte fu insolitamente freddo; gli Svizzeri, che avevano guadato fossati e canali e si erano inzuppati fino alle ossa, soffrivano ancora più il freddo; inoltre, non avevano da mangiare, da bere, non potevano accendere fuochi, rintracciare gli sbandati. Decisero di rimanere sul campo di battaglia, malgrado tutto, per conservare i vantaggi ottenuti nella lotta; i corni di Uri chiamavano spettrali nelle tenebre, a rianimare i disperati e ad ammonire chi tentasse di prendere il largo.

La battaglia
Quando, il mattino del 14, venerdì, la pugna venne ripresa, il Re aveva completamente riordinato il suo esercito; richiamata l’avanguardia, l’aveva incorporata nella massa centrale, schierando davanti artiglieria e fanti, e tenendo indietro, nascosta, la cavalleria. Due, tre volte gli Svizzeri lanciati all’assalto vennero respinti. Allora, un’ala dei Confederati tentò la manovra di aggiramento che a Novara aveva determinato la vittoria; essa, per altro, non riuscì, sventata dalla strategia del Re e da un fatto nuovo e decisivo: tanto i montanari quanto Francesco I° attendevano rinforzi; quelli dal Papa (truppe accampate a Piacenza), questo dagli alleati veneziani; ora, il grido che dai confini della pianura annunciava il sopraggiungere di nuove truppe era il temuto “San Marco!”; quella che stava disegnandosi ancora quale vittoria della Lega si trasformava così in una dolorosa disfatta. Il generale veneziano Alviano teneva il suo esercito a Lodi; nella notte, aveva ricevuto l’ordine di portarsi avanti, e ora, sul primo mattino, sorretta la retroguardia francese che stava sbandando, si gettava contro il fianco destro dei Confederati. Credettero essi che l’intero esercito di Venezia ruinasse loro addosso, mentre in realtà si trattava soltanto di alcuni reggimenti.
I collegati della Lega Santa (antifrancese), allocati a Piacenza, le forze spagnole e papali, nonostante i patti di alleanza, disertarono la battaglia, e non accorsero in aiuto del contingente elevetico.
Nello stesso momento, il Re scopriva la cavalleria che avventava il centro della contesa; essa aprì una breccia tra gli Svizzeri; gli alfieri di Uri, di Svitto, dei valorosi Grigionesi caddero nel sangue e con essi cadde la speranza di raddrizzare le sorti della lotta.
Venne allora decisa la ritirata su Milano. Quando i Francesi poterono irrompere indisturbati, ai loro occhi si presentò uno spettacolo miserando e nobile ad un tempo: tutti gli Svizzeri sfuggiti al fuoco delle artiglierie e alle violenze dei lanzi s’erano disposti in quadrato; al centro, tenevano i cannoni strappati dal fango delle paludi e che sospingevano o trascinavano a forza di braccia; sulle spalle, portavano i loro feriti e le bandiere, e così – composti, dignitosi, a passo lento, in un ordine molto più efficace di quel che avessero il giorno innanzi – marciavano verso settentrione. La leggenda vuole che Francesco I°, preso da ammirazione, come già alcuni decenni prima il Delfino di Francia a San Giacomo sulla Birsa, desse l’ordine di rispettare i valorosi sconfitti che si ritiravano; ma è leggenda: la verità è che i vincitori si diedero immediatamente a braccare i dispersi che, raggiunti, vennero trucidati senza pietà; trecento Zurigani che s’erano rifugiati in un convento a San Giuliano vennero cannoneggiati e, poi che resistevano anche alle artiglierie, bruciati insieme con l’edificio che li proteggeva.
I morti di Marignano non si poterono mai contare; le cifre tramandate dalla tradizione sono discordi, ma si calcola il loro numero a circa dodici mila, una cifra spaventosa; per decenni la pianura fu cosparsa di ossa. Il grosso dei superstiti ripassò le Alpi; a Milano, rimasero poco più di duemila uomini a presidio del Castello che resistette ancora per un mese.
Gli Svizzeri si diressero a Como e a Bellinzona, e dopo aver provveduto alla sicurezza di Lugano e di Locarno, giunsero tra le Alpi sul finire di settembre.
“Battaglia di Giganti” definì Marignano il maresciallo Trivulzio, aggiungendo che, a settant’anni d’età e dopo aver partecipato a diciotto campagne, non poteva rammentare lotta più tremenda e grandiosa di quel supremo duello con gli Svizzeri. Così nella tragedia di Zivido si chiudeva tutto un periodo di espansione degli Svizzeri e di lotte europee, e a un tempo un secolo della loro storia militare.

A ricordo della battaglia dei Giganti, nel 1965 fu posto, nel luogo degli scontri, un bassorilievo,
realizzato con granito del San Gottardo, delle dimensioni di m 3×2,
raffigurante un guerriero dell’epoca che difende un camerata moribondo.
Approfondimenti sulla battaglia
La pace e l’alleanza con la Francia
L’11 ottobre, dopo che Massimiliano ebbe consegnato il castello agli assedianti, contro la volontà della guarnigione svizzera (che ottenne la garanzia di ritirarsi indisturbata con i suoi feriti), il Re Francesco I° fece il suo ingresso trionfale a Milano. Il corteo di colui che su di una moneta coniata a ricordo della battaglia si chiamò orgogliosamente “Primus domitor Helveticorum” – il primo che abbia domato gli Svizzeri – sanzionava anche esteriormente il trionfo dei Francesi e l’abbandono della Lombardia da parte dei Confederati; e subito contingenti francesi si spinsero fino a Tresa, molestarono Lugano, saccheggiarono Locarno, decisi a riprendere anche le terre sotto il San Gottardo.
I Cantoni primitivi, in un ultimo slancio disperato, inviarono immediatamente rinforzi a Bellinzona, Locarno, Lugano, senza attendere le discussioni della Dieta e decisi a difendere i frutti della loro secolare politica gottardista; allora, le truppe francesi ripiegarono su Milano.
A occidente, invece, cioè nella Val d’Ossola, la perdita fu irreparabile e definitiva; Francesi e lanzi licenziati dal Re s’erano diretti su Domodossola, dove Giovanni von Diesbach, figlio dello Scoltetto di Berna, si affrettò a consegnare ai Francesi le chiavi della cittadina, non senza aver ottenuto un compenso in sonante denaro (“nit ohn Geld” annotò un cronista confederato); questo fatto, connesso con la simpatia che il Diensbach nutriva per la Francia dove era stato allevato quale “paggio” di corte, fece definire la cessione come un secondo tradimento: “il tradimento di Domodossola”; è evidente che fu la mancanza di chiaroveggenza – in certi Cantoni – sull’importanza strategica ed economica della vallata a sacrificarla, staccandola per sempre dalla Svizzera.
La Dieta, riunita subito dopo Marignano, prese talune decisioni che sembravano annunciare il proponimento di riconquistare la Lombardia e di continuare la guerra contro Francesco I°: levata di un esercito di ventiquattro mila uomini, più stretta alleanza con l’Imperatore, ecc. Ma furono decisioni non seguite dai fatti; praticamente, i Cantoni che non avevano partecipato alla “battaglia dei giganti” e che non sentivano la politica della Lombardia rinfocolarono la scissione che già esisteva tra gli Svizzeri, sostenendo l’opportunità di concludere la pace con il Re e accettando le proposte che quest’ultimo liberalmente aveva fatto balenare, grazie alla mediazione del duca di Savoia. I Cantoni occidentali che costituivano il partito della pace ebbero facile gioco quando arrivò in Svizzera la notizia che il grande alleato dei Confederati, colui per il quale lo Schiner aveva imposto la campagna del 1515 e la pugna di Marignano, Papa Leone X° aveva abbandonato gli alleati e, seguendo una politica di doppiezza e di “utile particulare”, s’era riconciliato con Francesco, l’aveva incontrato a Bologna, gli aveva ceduto Parma e Piacenza chiavi dell’Emilia, in cambio di certe egoistiche concessioni per sé e per la famiglia Medici.
I Cantoni occidentali avviarono così trattative, a Ginevra, con i rappresentanti del duca di Savoia; la loro base era il nefasto Trattato di Gallarate, che veniva completato con un progetto di alleanza tra il Re e gli Svizzeri.
Chiaro che i Cantoni sull’asse del San Gottardo, dai primitivi fino a Zurigo, a Basilea, a Sciaffusa, non volessero accettare le conclusioni di Ginevra; ne venne una nuova, grave scissione tra gli Svizzeri, che i nemici della Francia cercarono di approfondire; l’Imperatore si diede da fare, il Re d’Inghilterra Enrico VIII° cominciò a staccarsi dalla politica di Francesco(al quale aveva lasciato fino allora mano libera), la Spagna avviò nuovi preparativi di ostilità.
Sopra tutti, però, con accanimento implacabile, il cardinale Schiner si gettò in frenetiche trattative: dal Tirolo, dalla Svevia, da Costanza, con l’Imperatore, gli Svizzeri, il Re d’Inghilterra, onde mettere insieme una nuova alleanza contro l’odiato sovrano dei Francesi. La maggioranza dei Cantoni e il Vallese – ribelle al suo Principe-Vescovo – accettarono nel gennaio del 1516 le proposte stipulate a Ginevra e poco dopo il denaro che Francesco versò per la spedizione di Digione e le campagne del 1515 in Italia. Le potenze avverse alla Francia si appoggiarono allora sui cinque Cantoni gottardisti e sui Grigioni; un nuovo esercito venne arruolato e posto agli ordini dell’Imperatore Massimiliano; dai Grigioni passò nel Tirolo e, sempre guidato e infervorato dallo Schiner, giunse sotto le mura di Milano. Dentro la città stavano già mercenari svizzeri, assoldati da Francesco tra i Cantoni occidentali, onde il rischio di una nuova guerra fratricida; per fortuna, tanto gli assedianti quanto gli assediati, avviliti per la mancanza di denaro e di viveri, finirono per sciogliersi e per avviarsi verso i loro villaggi al di là delle Alpi. La campagna di Marignano, drammatica e gloriosa ad un tempo, si chiudeva così con questo vergognoso episodio, indice della squallida politica di coloro che soltanto con triste ironia si chiamavano ancora “confederati”.
Trionfava dunque la Francia, malgrado un ultimo tentativo del cardinale Schiner che, tra Impero, paesi bassi, Inghilterra, Spagna, si agitava onde costituire una lega “universale” contro di essa. Nel tardo autunno del 1516, a Friburgo, venne firmato tra gli Svizzeri e il Re di Francia un trattato di pace e di alleanza: il Re s’impegnava a versare le quattrocento mila corone di Digione, più altre trecento mila per la campagna conclusa a Marignano; ai Cantoni e loro alleati veniva riconosciuta una pensione annua di duemila ducati; ai Confederati, rispettivamente alle Leghe Grigie, restavano le terre del Ticino, quelle del Sottoceneri, la Valtellina e Chiavenne, salco che – nel termine di un anno – i primi non preferissero un ulteriore versamento di trecento mila corone, con la rinuncia ai territori di là del San Gottardo.
Ci si può domandare perché Francesco I° abbia avanzato proposte tanto generose; la ragione è la stessa che già dopo San Giacomo sulla Birsa (1444) aveva indotto il futuro Luigi XI°, allora Delfino, a un’intesa con i vinti: arruolare soldati tra quei robusti montanari per i quali il servizio mercenario costituiva la sola industria possibile; Francesco riuscì inoltre a fare degli Svizzeri, fino allora intesi a molestare e a invadere periodicamente la Lombardia, i suoi neutrali defensori. Egli ricevette con i più alti onori il capo di Zugo, G. Schwarzmurer, e quello di Friburgo, Peter Falk, recatisi a Parigi per sigillare il trattato di pace e, dimenticando che i due ambasciatori avevano svolto per il passato una politica antifrancese, li colmò di sontuosi donativi. Il comandante Schwarzmurer morì pochi mesi dopo aver rassegnato il suo rapporto alla Dieta, e due anni più tardi scomparve anche il Falk, travolto da una tempesta mentre navigava verso la Terra Santa.
L’accordo tra il Re e la Lega elvetica entrò in vigore nel 1521: l’alleanza assicurava alla Francia la fornitura di sei mila fino a sedici mila uomini; siffatta capitolazione, insieme alla pace perpetua, costituì la base delle relazioni franco-svizzere sino alla Rivoluzione, cioè per oltre due secoli e mezzo. Un Cantone soltanto si rifiutò di osservarla, Zurigo, e grazie all’azione patriottica e cristiana di Ulrico Zwingli; il cappellano dei Glaronesi era tornato dalle campagne d’Italia profondamente sconvolto; molti cittadini di Zurigo, indignati come lui, biasimavano pubblicamente gli speculatori delle pensioni straniere, i beneficiari di regali del Re, i soldati che non avevano esitato a depredare le chiese. Parole insolite di condanna si levavano dalla Zurigo di Zwingli, delle quali si trova un’eco nella dolente annotazione del cronista di Zugo, Werner Steiner: “Avessimo seguito più intensamente i suoi moniti, ci sarebbero state risparmiate molte sciagure; chi non crede, deve imparare ai propri danni, quand’è troppo tardi per evitarli”.
Cause remote e conseguenze della disfatta
Chi voglia rendersi conto di un avvenimento non può guardarlo isolatamente, ma deve cercare gli addentellati con altri fatti. Così per la sconfitta di Marignano; certamente il cardinale Schiner ha trascinato gli Svizzeri in un’avventura senza uscita, certamente la defezione dei Cantoni occidentali, dopo Gallarate, ha cagionato tremende conseguenze, certamente la carenza di un condottiero e di un piano strategico chiaro ha condotto alla disfatta. Possiamo tuttavia chiederci se le cause della catastrofe non vadano cercate più addietro, già nei primordi della storia svizzera, nella composizione del paese e del popolo e nello sviluppo della Lega.
Lo stesso principio del guardare lontano deve assisterci quando ragioniamo sulle conseguenze della guerra; quelle immediate furono naturalmente vergogna, strazio, disorientamento; alla lunga, però, anche il colpo più duro può generare benefici frutti di saggezza e mostrare la strada dritta; ciò è vero nella vita privata, lo è altresì nella vita di un popolo. Certe giornate fatali diventano allora una sorta di “esame” attraverso il quale si misura il valore di un paese; certe delusioni sono il solo mezzo che consenta a un popolo di guarire da eccessive e pericolose illusioni e di ritrovare la verità nuda dei fatti. Poteva svolgere la Svizzera la politica della grande potenza? Siffatta politica si confaceva alla sua costituzione statale?
La questione centrale: libertà oppure potenza? Lega o imperio?
Venne dunque dall’esterno l’imposizione a cessare una politica da grande potenza, ma essa corrispondeva anche all’interno carattere della Lega. Sarebbe perciò errato il ragionamento di chi attribuisce all’avversità di un crudele destino, che ha nome Marignano, il fatto per cui la Svizzera non sia diventata una potenza europea; si deve piuttosto dire che il breve periodo della grandezza militare fu un’avventura che contraddiceva al carattere stesso della Confederazione; in cambio di conquiste territoriali, gli Svizzeri smarrirono il senso del loro piccolo Stato.
La Confederazione era nata quale alleanza di minuscole e libere comunità che si assicuravano reciprocamente certi aiuti, entro determinati limiti e confini; verso mezzogiorno, ad esempio, i trattati di alleanza dei cantoni, ma non di tutti, impegnavano l’aiuto sino al Monte Piottino (Plàtifer); più a sud, si sarebbe dovuto discutere, caso per caso. La preoccupazione fondamentale dei primi Confederati era tuttavia la libertà delle loro vallate o delle loro città. Anche le guerre del primo secolo d’indipendenza erano state lotte per la libertà, contro i tentativi di assoggettamento e contro il mondo feudale. Quando gli Svizzeri presero Zugo non lo tennero quale paese di conquista, ma se ne fecero un’alleata, come già si è detto.
Ma cento anni dopo il Morgarten, le primitive preoccupazioni s’erano affievolite e la saggezza d’un tempo era dimenticata; occupata l’Argovia nel 1415, gli Svizzeri le imposero la loro “signoria”, non le concedettero né la dignità di Stato eguale ai loro, né la possibilità di un autogoverno. I Cantoni “signori” mandavano nei paesi di nuova occupazione i governatori (Fogti), scelti per turno, i quali davano scarico alla Dieta della loro amministrazione. Per una politica di dominio ci si era dunque allontanati dai principi della Confederazione.
L’impresa d’Italia giunse come inattesa occasione di grandezza; gli Svizzeri agirono senza dubbio saggiamente rinunciando a spezzettare la Lombardia in tanti piccoli baliaggi – come avvenne invece nelle terre ticinesi – e preferendo la forma del “protettorato” sul Ducato di Milano. Ma, fosse stato il Duca uomo d’altra tempra, capace di difendersi dalla politica aggressiva del Re di Francia, come sarebbe potuto continuare il “protettorato”? Non sarebbe venuto il giorno della riscossa milanese? Anche senza la disfatta di Marignano, dunque, si sarebbe giunti un giorno o l’altro alla prova che una Confederazione di piccoli Stati affatto autonomi non aveva la possibilità di governare un grande territorio quale la Lombardia o, più ancora, l’Italia settentrionale; e ciò che né il Machiavelli né il Guicciardini non compresero, ma che aveva capito bene l’ambasciatore fiorentino Vettori. Con la spedizione di Pavia era stato facile assoggettare tutta l’Italia subalpina, dal Veneto a Genova; non egualmente facile a una lega di minuscole repubbliche, con mentalità e preoccupazioni divergenti, il dirigere politicamente e militarmente un così vasto paese. Lo provò subito la decisione dei cantoni occidentali, guidati da Berna, di abbandonare il Piemonte di fronte a Francesco I° e di disertare l’impresa italiana; né forza alcuna avrebbe potuto trattenerli; in base all’alleanza tra i cantoni ognuno interpretava a modo suo l’offerta di pace del Re e ognuno decideva di conseguenza. In due parole, gli Svizzeri non avevano una politica estera.
Tutt’altra cosa nello Stato unitario, in particolare nell’unità francese rafforzata dall’assolutismo della monarchia e dalla energia di un Re autoritario quanto intelligente; là si perseguiva una solo politica, tenacemente con l’astuzia o con la forza, e tutte le possibilità dello Stato venivano piegate allo scopo. I Cantoni confederati non rinunciavano invece per nessuna cosa al mondo alla libertà di decisione, non arrendendosi mai e per nessun motivo a uno “stato di necessità” politica o militare. Nella condotta della guerra, lo stesso criterio: ogni Cantone i suoi capi, e la truppa tenuta a obbedire ai sui capi e al governo cantonale, non ad altri. Sarebbe stato necessario in Lombardia un esercito permanente, con un comando unico; esso avrebbe tenuto in rispetto i Francesi anche durante l’inverno, quando i passi alpini coperti di neve e il pericolo delle valanghe trattenevano al di là delle Alpi i Confederati. Ma era misura addirittura inconcepibile, per gli Svizzeri di allora.
(Solamente verso la metà del secolo scorso, con la trasformazione della “Confederazione di Stati” in un moderno “Stato federativo”, riconobbero i Cantoni la necessità dell’unità nell’esercito e nei comandi; da quel momento, tutta la difesa venne accentrata, con i suoi problemi di istruzione, di armamento, di gerarchia, di mobilitazione, di condotta operativa e di bandiera; agli stendardi dei Cantoni venne sostituita la bandiera federale svizzera; in caso di guerra, l’unità è ancor più salda, grazie alla nomina di un generale).
Un’altra circostanza facilitò la vittoria dei Francesi. Essi disponevano, come già s’è detto, di numerosa artiglieria. Era l’arma nuova, frutto delle scoperte e delle invenzioni del Rinascimento, ed era l’arma decisiva; Marignano lo dimostrò clamorosamente.
Ma per costituire un parco d’artiglieria occorrono capitali ingenti e unità tecnica, cose impossibili nella Confederazione d’allora, possibili invece al Re che sapeva impegnare tutta la nazione per lo sforzo bellico in corso.
(La sopra accennata trasformazione dello Stato nel 1848 ha consentito alla Svizzera l’unità della politica estera e l’unità costantemente aggiornata degli armamenti. Con ciò, non si è intaccato profondamente il principio del federalismo; i 25 piccoli Stati confederati sono sempre la fonte della libertà che conservano quasi inalterata nelle faccende della loro politica interna, della loro cultura, della scuola, della polizia e in altri campi ancora. E tuttavia si deve aggiungere che le circostanze della vita internazionale, i problemi politici ed economici che le ripetute crisi del mondo hanno imposto alla Svizzera tendono a limitare sempre più la sovranità dei cantoni e la stessa libertà dei cittadini, in favore dello Stato, cioè del centralismo economico e amministrativo).
La condotta del cittadino e del guerriero
Non dobbiamo trascurare, nelle cronache del tempo di Marignano, l’evoluzione del costume morale del singolo cittadino. Le guerre, come osserva esattamente Emilio Dürr “permettevano in genere un larghissimo impiego delle principali qualità nazionali: genere di vita semplice, senza pretese, e innato valore militare. Gli arruolamenti per il servizio estero, poi, servirono ad ottenere contrattualmente privilegi commerciali e di comunicazioni negli Stati vicini.
Sono, questi, motivi materiali quasi superiori, radicati solidamente in quel potente e traboccante materialismo che è caratteristico di un’epoca tutta esteriorità, la quale non solo aprì nuove fonti di guadagni e di oro, ma stava per spezzare ben presto in un modo o in un altro i vecchi vincoli religiosi”.
Discordia nella Lega, dunque, nei cantoni, nei governi e nelle popolazioni; la Dieta non disponeva di sufficiente autorità per imporre disciplina, data la forma associativa dello Stato; ma, purtroppo, nemmeno i suoi rappresentanti, i Capi dei cantoni, godevano di quell’autorità morale che permettesse di tenere in freno le folle. “Così gli Svizzeri partivano in massa, a loro piacimento, secondo l’abitudine di quasi cinquant’anni, incuranti della loro responsabilità o senza preoccuparsi degli interessi politici reali della Confederazione, senza darsi pensiero di sapere se non si sarebbero scontrati con Confederati o magari con un loro proprio compaesano del campo avverso.
Questa indisciplina del popolo era stata certamente facilitata dalla corruzione politica delle classi dirigenti, poiché rappresentanti audacemente egoisti e spregiudicati delle stesse si erano eccessivamente solidarizzati coi sistemi materiali allora in vigore negli Stati esteri per il reclutamento degli eserciti europei, quali partigiani e favoreggiatori, quali agenti di arruolamento, fornitori di truppe e capitani, quali beneficiari di pensioni pubbliche e segrete, di stipendi, di noli e donativi (Miet und Gaben), come allora si diceva di solito … Così si ebbe allora in Svizzera una politica estera torbida e falsa, un misto di interessi realistici, di simpatie calcolate o impulsive, d’egoismo robusto e basso delle folle e degli individui. In questa situazione, tutto quanto il paese ebbe in qualche modo la sua parte di responsabilità”. (Dürr)
Nella letteratura popolaresca dell’epoca, specie in quella che mette capo alla Riforma, si trovano critiche, deplorazioni, biasimi, ironia; la lettera di Zwingli agli antichi Confederati, esortante a tornare alla serietà morale delle origini della Svizzera, fu diffusa ovunque e suscitò ondate di discussioni; ancor oggi, si legge come un capolavoro di oratoria civile e morale; cronisti dell’epoca parlano con disgusto di taluni capi che senza faticare molto, cioè grazie all’oro straniero, “posson portare giubbe rosse e cappello”; si voltassero per aria, “pioverebbero dalle loro tasche ducati e corone che sono il prezzo del sangue di figli, fratelli, cugini e cari amici tuoi”. Quale decadimento, in verità! I nipoti di quei Confederati che nel 1291 avevano cacciato i magistrati corrotti e venali, ora si lasciavano comprare dai Principi d’Europa ai quali vendevano la gioventù dei loro villaggi.
Tornavano ogni tanto alla memoria talune patetiche esortazioni dell’eremita del Ranft, Nicolao della Flüe; si alzavano aspre, nello stesso senso, le rampogne dello Zwingli; sulle scene delle città venivano rappresentati lavori teatrali e farse che mettevano alla gogna il mercenario fanfarone, i nuovi ricchi delle pensioni straniere, la Lega asservita al denaro, e contrapponevano a quelle scene l’austerità dei fondatori della Svizzera; il gioco scenico del “Tell di Uri”, nato allora, intendeva stimolare la riflessione del popolo intorno allo squilibrio dei valori che insozzava tutta la vita elvetica.
D’altra parte, alcuni umanisti si dilettavano in raffronti tra la Confederazione d’un tempo e le “polis” dell’antica Grecia o la “Res publica dei Romani”, nella pietosa illusione che gli esempi potessero determinare una rinascita di virtù civiche e morali.
E’ da rilevare finalmente come il contatto con l’Italia dell’umanesimo abbia influito positivamente, quale raffinamento del gusto, ansia di belle cose, arricchimento della cultura, sui più sensibili tra i Confederati; basta fare i nomi dello Zwingli, dello scrittore, artista e magistrato bernese Niklaus Manuel, del lanzo estroso Urs Graf.
Verso la riflessione
Ma l’umanesimo era anche, nell’intimo, un ritorno al paganesimo – Ulrico Zwingli lo comprese subito – ai beni, alle gioie della terra. Se da un lato esso determinò un maggior piacere nella vita materiale, il gusto per ciò che è terreno e prezioso e squisito, dall’altro segnò un allentarsi della disciplina morale, cioè della concezione cristiana dell’esistenza, onde l’insorgere della Riforma e, successivamente, della Controriforma cattolica. La rivolta dello Zwingli cominciò appunto quale campagna contro il mercenarismo corruttore, continuò quale protesta contro l’ignoranza del clero campagnolo, per attaccare finalmente l’ordinamento della Chiesa e il dogma. La Chiesa era in quel tempo vulnerabilissima: il Pontefice offriva l’esempio di una politica terrena materialistica, egoista, volta a vantaggi personali e di famiglia e l’esempio, sopra tutto con Giulio e con Leone, di uno sforzo dispendioso rivolto a fare di Roma una capitale splendente di tesori artistici, di sfarzo, di eleganza, ma anche di lusso e di piaceri.
Ai soldati che rientravano avviliti dalle campagne mercenarie, il riformatore di Zurigo, deluso anche dalle ragioni degli umanisti, chiedeva instancabile: “Che cos’hai tu, che cos’abbiamo noi tutti di cristiano, tolto il nome?” Dalla cultura dell’epoca egli rifuggiva ormai per rifugiarsi nella religione pura, negli episodi del vangelo.
Dal 1519, inizio della sua missione quale parroco del Duomo di Zurigo, comincia la lotta per la Riforma nella Svizzera alemannica, sulla base di quel Nuovo Testamento che Erasmo da Rotterdam aveva pubblicato in accurata lezione greca e che Zwingli intendeva recare tra il popolo, nella lingua stessa del popolo.
Ma anche dall’altra parte, quella cattolica, venne avviata dopo non molti anni una riforma, precisamente la “riforma cattolica o controriforma”; si propose essa di rinvigorire il corpo della Chiesa, la disciplina interna, la morale cristiana, le basi stesse dell’insegnamento, cioè di fissare la dottrina nelle sue radici dogmatiche e nei sacramenti. Uno dei suoi propugnatori più infuocati e illuminati fu San Carlo Borromeo che si preoccupò moltissimo delle relazioni tra Chiesa e Confederazione; per preparare meglio il clero svizzero, il Borromeo fondò a Milano il “Collegium Helveticum” che dotò liberalmente, con sacrificio di una parte delle ricchezze della sua illustre famiglia.
Riforma e Controriforma agirono entrambe quali moralizzatrici della vita in Svizzera, richiamando i Confederati a certa serietà e a certi reciproci impegni, e, nell’esaltare i motivi dell’antica alleanza, rammentando loro i doveri delle vita cristiana e della modestia.
Un altro genere di modestia cominciò ad essere oggetto di riflessione. “Dopo Marignano e la pace perpetua, la Confederazione passò dalla sua secolare politica aggressiva ed espansionistica ad un atteggiamento difensivo” (Dürr); l’espansione territoriale aveva avuto uno sviluppo organico, secondo il carattere federalista dei Cantoni, favorito dall’innato valore militare e variamente guidato da ragioni economiche e commerciali. L’influsso politico in Italia durò fin che i due gruppi (il centrale e l’occidentale, San Gottardo e Borgogna) si accordarono. Per questo “in sé, la politica milanese non era stata un errore … come non erano state una caricatura nazionale e militare le vittoriose campagne contro l’Austria, la Borgogna, l’Impero. Gli stessi sforzi fatti incessantemente e con vario risultato dalle grandi potenze europee per conchiudere alleanze con i Confederati costituiscono una prova oggettiva del valore militare di questi ultimi e della loro importanza politica” (Dürr).
La pace del 1516 significa quindi rinuncia a una politica europea. Si stavano formando (o già s’erano formate) le nuove grandi realtà nazionali europee: Francia, Spagna, Inghilterra, Svezia, Russia, ecc. Con l’alleanza di Friburgo e con la conquista delle terre ticinesi, la Confederazione inglobava nel suo corpo terre e genti di altra nazionalità, d’altra lingua e concezione di vita; il partecipare alle guerre europee di predominio avrebbe significato un trasportare nell’interno del corpo confederale i motivi di discordia che agitavano le monarchie nazionali dell’Europa, quindi un mettere costantemente in pericolo l’assetto confederale. Talune frontiere nazionali erano state raggiunte: il Reno, il Giura, la regione dei laghi insubrici; perdurare in una politica ambiziosa di espansione poteva spingere allo scioglimento della Lega.
Col tempo, siffatte considerazioni si fecero strada negli animi degli Svizzeri, così che essi giunsero a una politica di “astensione” dai conflitti europei, che tre secoli più tardi si sarebbe definita politica di “neutralità” e sarebbe stata contrattualmente imposta alla Svizzera con il Trattato di Vienna e di Parigi del 1815.
L’acquisto durevole: la Svizzera italiana
Già dal 1440 gli Urani occupando definitivamente la Leventina avevano incorporato nella Svizzera un territorio d’altra lingua, italiano per parlata, mentalità e tradizioni.
Alla vigilia della rapida guerra di Svevia, gli Svizzeri s’erano alleati con la piccola Confederazione delle Leghe Grigie, cioè avevano stabilito legami di amicizia e di solidarietà con genti di cultura retroromancia e italiana; le Valli italiane dei Grigioni s’erano ingrandite – quanto a importanza di latinità – con l’acquisto grigionese della Valtellina, di Chiavenna e di Bormio. Ora, mentre queste ultime terre andarono perdute dopo il 1797, cioè al tempo della prima campagna napoleonica, le contrade del Ticino rimasero “signoria” dei Confederati fino al 1798, quando decisero di liberarsi, ma di rimanere tuttavia con gli antichi signori e padroni.
“Liberi e Svizzeri” risuonò il motto dei Luganesi prima, degli altri Ticinesi poi, e la decisione non cessa di stupire lo straniero che si chini sulla storia delle nostre contrade; i Ticinesi, cioè, preferirono restare, da pari a pari, con le genti d’oltre San Gottardo, diverse per razza, lingua, religione, mentalità, piuttosto che aggregarsi alla Repubblica Cisalpina e ai Milanesi che erano della stessa stirpe e religione, mentalità e costumi, e che parlavano la stessa lingua, anzi lo stesso dialetto. Il generale Bonaparte, che aveva consentito il distacco della Valtellina dai Grigioni, approvò invece la decisione del Ticino, forse per non inimicarsi gli Svizzeri dai quali si proponeva (come il Delfino del Quattrocento, come Francesco I° nel Cinquecento) di trarre soldati per le sue avventure in Europa. Le terre ticinesi rimasero dunque svizzere. Nel 1803, anzi, proprio per la Mediazione del Primo Console di Francia, divennero Cantone, cioè Stato autonomo e indipendente.
Da allora, il Ticino seguì la sorte del resto della Svizzera, ma consapevole del proprio destino e intento a costruire il proprio apparato statale sul modello degli altri Stati confederali.
Malgrado un Ottocento tutto trascorso da traversie e da difficoltà – l’incessante lotta tra i suoi due partiti “storici”, con intemperanze d’ogni sorta; l’inimicizia di talune potenze straniere che lo occuparono militarmente, come avvenne tra il 1810 e il 1812 per opera del Regno Italico di Napoleone e di Eugenio Beauharnais, o lo angariarono in ogni modo, come fece l’Impero Austro-Ungarico; la trasformazione della Confederazione in Stato federativo che tolse al Cantone la direzione della sua politica doganale ed economica, isolandolo crudamente tra la frontiera politica e la barriera delle Alpi – malgrado tante traversie e difficoltà, ripetiamo, il Ticino riuscì a costruire il suo edificio statale e a rivaleggiare con i più anziani Cantoni che godevano di ininterrotta libertà e di un assetto economico secolare.
Fu, anzi, la sua particolarità di unico Stato di cultura italiana libero e autonomo in Europa che gli consentì di dare un aiuto tanto considerevole alla causa della libertà e dell’unità italiane; la partecipazione del Ticino (Stato e popolazione) alla vicenda del Risorgimento è la grande pagina della sua storia, accanto a quella dell’emigrazione artistica di costruttori, impresari, architetti, artisti che lasciarono in ogni parte d’Europa – da Mosca e da San Pietroburgo (Leningrad) fino alla Spagna, dal Mare del Nord alla Sicilia e a Costantinopoli, ma sopra tutto in Italia, le testimonianze d’una straordinaria genialità e, quasi, di un naturale, prodigioso istinto del costruire.
Allo Stato federativo svizzero, il Ticino ha offerto statisti di vasta operosità e di eccezionale talento, quali Stefano Franscini e Giuseppe Motta; ha offerto e offre scrittori, uomini di scienza, economisti, docenti universitari, magistrati d’alto valore. Dal punto di vista svizzero, si deve quindi salutare con particolare soddisfazione la politica gottardista dei cantoni centrali, che permise la formazione di una Svizzera italiana (Ticino e Valli grigionesi) e, con ciò, la configurazione di una Svizzera quadrilingue, di diverse stirpi e fede religiosa, e tuttavia unita nell’ideale della volontaria collaborazione pacifica, cioè nell’affermazione della ragione e della buona volontà sulle passioni e sugli altri elementi irrazionali.
E che cosa rappresenta per la Svizzera italiana, il fatto di essere parte integrale della Confederazione? Vantaggi d’ordine politico che nessuno può dimenticare: quasi cinque secoli di pace ininterrotta; l’esigenza di un certo livello economico di esistenza; una provata educazione democratica (che si vorrebbe dire frutto d’esperienze secolari) che è disciplina e anche senso di solidarietà tra le classi sociali, che in Svizzera non sono separate da abissi come altrove, ma tendono a un livello di media prosperità; di più, dal punto di vista svizzero, la condizione del Ticino gli ha conferito l’impegno, e però anche il vantaggio, di essere uno “Stato”, se anche non più interamente sovrano, sempre però indipendente e largamente autonomo; questo vuol dire, ancor oggi, certa libertà di movimenti e dovere di emulazione con gli altri “Stati” confederati, e doveri in genere, obbligo di serio lavoro per sviluppare istituti civili, raggiungere posizioni materiali, conservare dignità di Cantone, anzi di “Svizzera italiana”.
La comunanza etnica e culturale con la gran madre, l’Italia, oltre a dargli l’orgoglio di un’antichissima e umanissima civiltà, il ricordo di mezzo secolo di collaborazione al Risorgimento, gli affida poi delle responsabilità particolari, e dovrebbe dargli altresì una sensibilità particolare.
Ritiro dalla storia del mondo? La neutralità
S’è già parlato della nuova politica di astensione dai conflitti nazionali europei, caratteristici della storia moderna con le sue lotte di predominio, poi di equilibrio. Nel 1815 l’astensione venne ufficialmente consacrata in un patto internazionale, riconoscendo le grandi potenze che la neutralità della Svizzera, così come la sua indipendenza dall’influsso di altre Nazioni, è nel reale interesse dell’Europa intera. Così la politica che fu seguita dopo Marignano determinò la vita ulteriore della Confederazione, evitandole per sempre, di poi, d’essere trascinata nei conflitti nazionalistici e imperialistici che straziarono l’Europa. “Ex clade salus”, dalla disfatta è nata la salvezza ulteriore per la Svizzera.
La politica di neutralità, concepita all’inizio quale semplice astensione, s’è poi svolta nel nostro secolo in un senso attivo e universalmente benefico; del resto, lo aveva già previsto un grande ospite del Ticino, Carlo Cattaneo, vissuto a Lugano dopo il 1848; in una sua pagina mirabile per intuizione politica, l’esule milanese preannunciava l’opera incessante di “costruzione di ponti” tra le nazionalità dell’Europa, resa possibile dalla nuova politica della Confederazione, di quei ponti che le guerre dell’imperialismo distruggono brutalmente; è la definizione della neutralità “attiva”, tanto evidente durante la prime e seconda guerra mondiale, quando la Svizzera fu asilo di innumerevoli perseguitati, di esuli d’ogni contrada, e aggiunse a tale sua assistenza ai derelitti la protezione degli interessi di moltissimi Stati del mondo intero, l’assistenza ai feriti, ai partigiani, ai bambini dell’Europa, senza distinzione di nazionalità.
Grazie alla neutralità, nel 1859 Enrico Dunant concepì il progetto di un’istituzione d’assistenza ai feriti nelle battaglie, e nel 1864 nacque a Ginevra la Croce Rossa internazionale.
Va finalmente osservato che la neutralità nostra ha caratteristiche sue particolari: è contrattuale, riconosciuta da noi e dalle potenze che la codificarono; è perpetua e non occasionale; è armata, cioè protetta dal nostro esercito, ed è benefica. Essa ha consentito alla Svizzera, fin dai tempi di napoleone, di conservare intatte e immutate le sue frontiere, unico paese in Europa a godere di tale privilegio.
I compiti del piccolo Stato
Oggigiorno, nello spazio di ventiquattr’ore – quanto durò la battaglia di Marignano – si può compiere almeno quindici volte il giro intorno alla terra; i cosmonauti lo hanno dimostrato. Ci si domanda, allora: il piccolo Stato neutrale ha ancora una ragione d’essere e una giustificazione?
Se la si misura a metri quadrati di superficie, la Svizzera è soltanto la duecentesima parte del Brasile, essa ha soltanto la seicentesima parte della popolazione della terra. Ai fanatici della carte geografiche e delle statistiche non è lecito tuttavia d’includere nei loro calcoli certi valori che possono essere riscontrabili nel piccolo Stato quanto nell’immenso impero (e magari più e meglio nel primo che non nel secondo).
Indichiamone alcuni. Nel piccolo Stato, il cittadino può scrutare le vicende della vita statale più accuratamente.
Egli si sente parte viva dello Stato, perciò assume più volentieri le sue responsabilità. Non è smanioso di potenza e, invece, è propenso alla pace e alla comprensione. “Il piccolo Stato – diceva Jacopo Burckhardt – non ha in fondo nient’altro che la libertà, ma con quella riesce a equilibrare i vantaggi, addirittura la potenza dello Stato grandioso”; il filosofo della storia ha ragione. L’Attica antica, la Firenze dei Medici, il ducato di Sassonia-Weimar che ricorda Goethe e Schiller non erano più vasti né più popolosi di un nostro Cantone; eppure, videro fiorire dentro i loro confini una civiltà che nessun impero gigantesco poté eguagliare. Lo storico delle Costituzioni svizzere, Carlo Hilty, e il presidente Giuseppe Motta hanno più volte affermato: “A un piccolo Stato un solo orgoglio è possibile: rivaleggiare con le grandi potenze nell’ardua ricerca della grandezza morale”.
Non è soltanto utile per l’Europa, ma per il mondo intero, che gli Svizzeri sappiano conservare la loro pace interna, mostrare l’esempio di una leale collaborazione tra genti di stirpe e di lingua diversa, far primeggiare l’educazione democratica che è spirito aperto, abitudine alla discussione e alla tolleranza, rispetto per le opinioni degli altri. Si è detto “educazione democratica”; lo affermò già Enrico Pestalozzi, il buon genio della vita elvetica, il confederato più noto nel mondo: “Senza educazione politica, il popolo che diciamo sovrano è un ragazzo che scherza col fuoco e mette in pericolo la casa di tutti”. E’ appunto nell’educazione alla vita politica e sociale che il grande educatore ravvisava il contributo spirituale della Svizzera alla civiltà umana.
Se intende compiere codesta missione educativa, il piccolo Stato non deve conoscere soltanto il diritto all’esistenza, ma il dovere di lavorare per la vita dell’umanità e per il suo progresso. Così la nostra Patria potrà conservare il suo volto e il suo valore, anche nell’avvenire.
Georg Thürer
Guido Calgari
Bibliografia essenziale
Emilio Bontà, “La Leventina nel Quattrocento”, edizione La Scuola, Bellinzona.
Albert Büchi , “Kardinal Matthäus Schiner”, 2 volumi, Friburgo 1937.
Guido Calgari, “Storia delle quattro Letterature della Svizzera”, 1959.
Johannes Dierauer, “Geschichte der Schweizerischen Eidgenossensdchaft”, 2 volumi, 1920.
Emil Dürr, “Storia militare svizzera”, traduzione di Celestino Trezzini, fasciolo 4°, 1954.
S. Frey, “Le guerre milanesi, Storia militare svizzera”, traduzione di Celkestino Trezzini, fasciolo I°, 1915.
Ernest Gagliardi, “Histoire de la Suisse”, traduzione di A. Reymond, Lausanne, 1925.
Ernest Gagliardi, “Der Anteil der Schweizer an den italienischen Kriegen”, Zurigo, 1919.
Francesco Guicciardini, “Storia d’Italia”. Ettore Janni, “Gli Svizzeri esaltati in un poemetto del Cinquecento”, Svizzera italiana n.84, 1950.
Hans Rudolf Kurz Schweizer Schlacten”, Berna, 1962.
Niccolò Machiavelli, “Il Principe, Discorsi…, Lettere”
Karl Meyer, “Ennetbirgische Politik und Feldzüge der Innerschweizer bis zum Siege von Giornico”, Storia militare svizzera, traduzione di Celestino Trezzini, fascicolo 3°.
Eligio Pometta, “Come il Ticino venne in potere degli Svizzeri”, Bellinzona, 1915.
William E. Rappard, “Cinq siècles de sécurité collective”, Parigi e Ginevra, 1945.
G. Rossi e E. Pometta, “Storia del cantone Ticino”, Lugano, 1941. Karl Tanner, “Der Kampf ums Eschental. Schweizer Studien zur Geschichtswissenschaft”, IX° volume, Zurigo, 1964.
Georg Thürer, “Geschichte und Verfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft”, Zurigo, 1964.
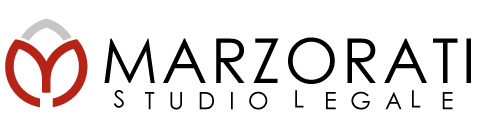
Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Sentitevi liberi di contribuire!